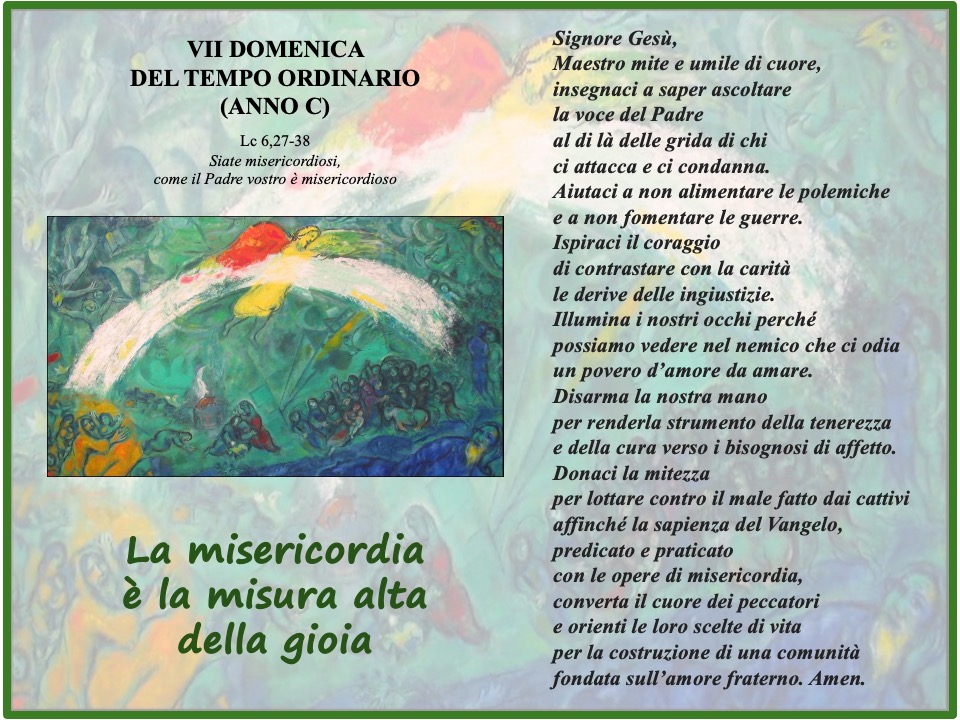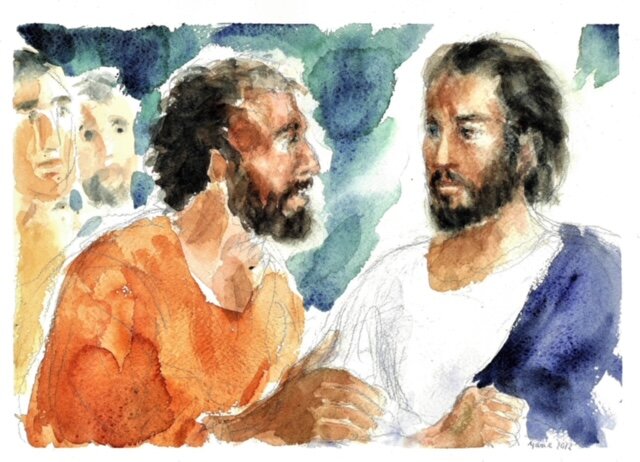
La misericordia è la misura alta della gioia – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) – Lectio divina
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) – Lectio divina
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 Sal 102 1Cor 15,45-49
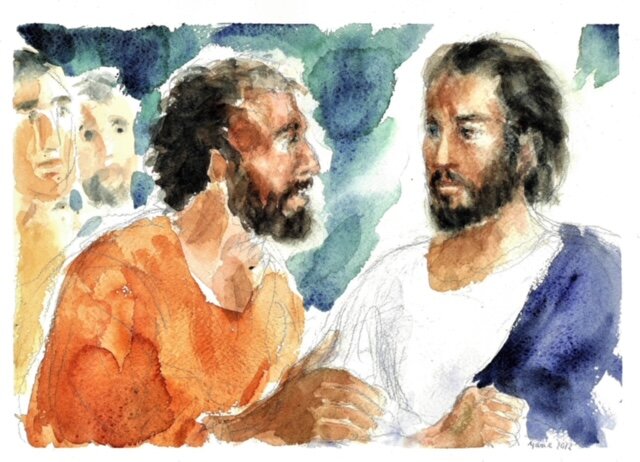
Padre misericordioso,
che fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi,
rendici capaci di perdonare chi ci fa del male,
affinché il nostro amore non conosca nemici, e viviamo da figli
e fratelli in Cristo Signore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Dal primo libro di Samuèle 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano.
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé tremila uomini scelti d’Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif.
Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?».
Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore.
Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte; vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re: passi qui uno dei servitori e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore».
Davide, il giusto messo alla prova
L’episodio s’inserisce nel conflitto tra Saul e Davide che è visto dal re come un suo pericoloso concorrente. L’invidia arma la mano di Saul che per due volte aveva cercato di uccidere Davide con la lancia. Abisai riconosce che Dio ha creato l’occasione perché sia fatta giustizia. Davide, che avrebbe avuto il diritto di difendersi, rinuncia ad uccidere il suo persecutore. Davide incarna l’immagine del povero dichiarato beato da Gesù, infatti, rinunciando a farsi giustizia da sé, affida la sua causa e il suo nemico a Dio perché, essendo il re un consacrato, la sua vita appartiene a Lui. Davide è modello del povero perseguitato che respinge la tentazione, espressa dal suggerimento di Abisai, e crede nella ricompensa che Dio gli darà per la sua giustizia e fedeltà. La distanza tra Davide e Saulo non è solo fisica ma ha anche un valore simbolico. Davide assume un comportamento opposto a quello condotto da Saul perché non s’ispira alla logica tipicamente umana della reciprocità tra punizione e colpa ma incarna quella divina il cui amore è generatore di vita e mai seminatore di morte.
Salmo responsoriale Sal 102
Il Signore è buono e grande nell’amore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1Cor 15,45-49
Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste.
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita.
Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale.
Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo. Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così anche i celesti.
E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste.
Nuove creature nello Spirito
L’Apostolo Paolo fa un raffronto tra il primo Adamo e il secondo, ovvero tra l’uomo-creatura che riceve il soffio vitale da Dio (cf. Gn 2,7) e l’Uomo-Creatore che dona lo Spirito della Vita. Sono entrambi Adam, quindi aventi un corpo, ma il primo, se rimane legato alla terra, alla terra ritorna, se invece accoglie lo Spirito dell’Uomo celeste, appartiene a Dio e diventa capace egli stesso di dare vita, amando. Con il Battesimo l’uomo terrestre riceve lo Spirito dal Cristo crocifisso e risorto in virtù del quale progressivamente Dio lo rende a immagine e somiglianza del Figlio. Diventando figli nel Figlio anche noi da appartenenti alla terra diventiamo cittadini del Cielo.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,27-38
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
LECTIO
Contesto
Dopo le «beatitudini» e i «guai», che hanno dato speranza ai giusti sofferenti e messo in guardia i falsi discepoli dall’operare iniquità, il discorso continua con un tono fortemente esortativo e con un linguaggio che intende essere normativo e offrire delle precise regole di comportamento. Il genere letterario rimane quello sapienziale che attinge il suo contenuto dalla tradizione sia greca che ebraica.
Testo
La pericope liturgica la possiamo dividere in due parti, ciascuna delle quali gira attorno ad una massima o regola (vv. 31.36) ed è introdotta dal medesimo precetto: «amate i vostri nemici» (v. 27.35). Nella prima parte ci sono quattro imperativi (vv. 27-28), tre esempi di non resistenza (vv. 29-30) e la regola d’oro che funge da centro di questa parte del discorso (v. 31). Seguono tre obiezioni (vv. 32-34).
La seconda parte della pericope è introdotta dalla ripetizione del comando dell’amore verso gli avversari con l’aggiunta di altri due imperativi, la promessa o vocazione, che chiarisce il fine dell’obbedienza al precetto, e l’indicazione del modello di condotta che trova nella benevolenza dell’Altissimo la causa prima (v.35). L’esortazione all’essere misericordiosi (v. 36), che assume un ruolo centrale nella seconda parte del brano, è seguita da quattro sentenze, due negative (v. 37ab) e due positive (vv. 37c-38a); la pericope si conclude indicando il criterio del giudizio finale riservato a ciascuno che deve essere criterio di discernimento dei propri giudizi (v. 38b).
Tutto il discorso verte sul tema dell’amore verso il prossimo e in particolare verso il nemico, declinato in quattro imperativi, quante sono le beatitudini e i guai. Come sono tre le forme di persecuzione con le quali si manifesta l’odio dei nemici («vi escluderanno, insulteranno e respingeranno», v. 22), così è triplice la risposta d’amore del discepolo fedele che «fa del bene, benedice e prega» a favore del proprio avversario. L’amore richiesto non è un sentimento, ma è amore di volontà che richiede un’azione proattiva per il fratello nemico.
Il discorso viene esplicitato con tre esempi di non resistenza: al mandante del giudice che punisce con percosse, al creditore che porta via il mantello (dato in pegno), al bisognoso che chiede un prestito senza dare garanzie. Dopo tre atteggiamenti positivi sono elencati tre rinunce: al rancore che genera la violenza, al risarcimento che blocca la giustizia sul piano meramente materiale, alla speculazione che aggrava la sperequazione. Queste situazioni descrivono relazioni difficili tra le persone che appartengono ad una comunità nella quale s’innescano dinamiche conflittuali originate da problemi di carattere economico e sociale. Dunque, il contesto tematico riguarda la gestione di conflitti per i quali si indicano un criterio e uno stile di comportamento. Non si suggerisce la passività ma una risposta che sia di segno opposto al gesto iniziale affinché il valore della persona sia anteposto a quello dei beni materiali che sono oggetto di controversia. Porgere l’altra guancia, aggiungere la tunica (considerata la seconda pelle di una persona) al sequestro del mantello, non richiedere indietro (con gli interessi) ciò che è stato dato in prestito, sono atteggiamenti che testimoniano, senza tanti discorsi, l’amore alla persona, nonostante tutto, piuttosto che l’attaccamento ai beni materiali.
Gli esempi sono presi dalla vita di tutti i giorni che rischierebbe di essere vista come un insieme assurdo di eventi senza la parola di Gesù che non indica tanto un ideale irraggiungibile ma la via, che lui stesso ha inaugurato, per vincere il male con il bene. Ad un occhio attento si possono scorgere negli esempi il profilo di Gesù quale Servo sofferente, soprattutto come è descritto in Is 50,6. La novità non è nel superamento delle barriere ideologiche delle tradizioni culturali, sia ebraica che greco-romana, ma nel fatto che la possibilità di andare oltre il «dovere», prescritto dalla legge e dalle convenzioni sociali, è una realtà che si concretizza a partire dalla vita donata del Cristo che sulla croce inaugura il Regno di Dio.
La fraternità è la ragione dell’amore ed è la speranza che muove l’uomo a testimoniare il bene a chi nutre sentimenti di odio, a riconoscere e valorizzare il bene di cui l’avversario è capace nonostante il suo atteggiamento che tende a demonizzare, a intercedere per la salvezza di colui che invece sparge male con la sua bocca. Gesù non invita alla passività ma ad assumere un atteggiamento che tende a fare del nemico un fratello. Amare il nemico non è innanzitutto una virtù umana che fa da condizione per elevarsi su un piano più alto di umanità, ma è dono divino offerto per progredire nel cammino di umanizzazione e conformazione a Cristo, crocifisso e risorto.
Le tre obiezioni, che sono domande retoriche, sono poste in un ordine che va dal generale «amare» al particolare «prestare». Amare non è solo una pia intenzione ma deve tradursi in stile di vita che si rivela soprattutto quando sono in discussione i beni materiali e in gioco le relazioni fraterne. Non è problematico il fatto che si creino conflitti ma lo è il modo con cui li si affrontano. È lì che si rivela se l’amore al prossimo è un principio astratto o il criterio con il quale discernere l’atteggiamento da usare nei conflitti. In definitiva, la domanda vera è: su quale speranza si poggiano le relazioni fraterne? Il comandamento dell’amore è un principio che serve per conservare l’equilibrio dei rapporti o per sanare relazioni ferite? Quale giustizia si persegue? Provocatoriamente Gesù alza il livello dell’esigenza dell’amore puntando l’attenzione su un piano superiore rispetto a quello di una pacifica convivenza tra le persone.
Per comprendere il fine provocatorio di queste domande è necessario ritornare a quella che è chiamata la «regola d’oro» e che è definita da Matteo come il compendio della «Legge e Profeti»: bisogna fare agli altri ciò che ci si aspetta da loro (cf. v.31). Si deduce, quindi, che il metro di misura della speranza è il proprio io. Tuttavia, se ci si limita a praticare la giustizia «retributiva», che in definitiva è poggiata sul principio della salvaguardia per proprio interesse, non si è differenti dai «peccatori» la cui speranza non va oltre la propria vita mortale.
Gesù instaura un confronto tra l’amore di cui sono capaci gli uomini peccatori e quello che invece caratterizza gli uomini santi (beati). I peccatori s’ispirano alla logica della reciprocità, mentre i santi a quella della gratuità. Alla luce del cambiamento di prospettiva si deve rileggere la «regola d’oro»: se riconosciamo di essere bisognosi dell’aiuto degli altri e quindi siamo nella condizione di essere debitori allora ci aspettiamo dagli altri quell’amore che veramente ci sostiene nelle difficoltà, ci accoglie nel momento della solitudine, ci incoraggia e ci libera dalla paura. Solo un amore gratuito rende responsabili, ovvero capaci di restituire ai fratelli nel servizio ciò che abbiamo ricevuto senza calcoli d’interesse.
Nella seconda parte della pericope (v.35s) Gesù dà seguito alle tre obiezioni indicando nell’essere figli dell’Altissimo (di Dio) il motivo e il fine dell’amore al nemico. La novità del vangelo consiste nell’ampliamento universale dell’amore e nella sua gratuità, diversamente dalla logica ebraica della selezione e della separazione e da quella greco-romana che prende come criterio la reciprocità. In altri termini, le tre obiezioni mettono a tema la necessità di una decentralizzazione dal proprio «io» e dal «secondo me» per ricentrare la prospettiva nel punto di vista di Dio.
Gesù, che l’angelo Gabriele aveva chiamato «figlio dell’Altissimo» si propone come modello e misura dell’amore e della giustizia da praticare. Il titolo «Figlio dell’Altissimo» definisce Gesù come il Cristo, Figlio di Dio. La misericordia è la caratteristica propria di Dio Padre e Gesù la indica anche come la peculiarità dei suoi figli. Giusto non è l’uomo che osserva la Legge nei suoi aspetti formali ma chi ne assimila e incarna lo spirito e, in tal modo, diventa misericordioso. L’amore misericordioso è la misura più alta della legge perché è l’essenza della paternità di Dio. L’essere misericordioso è la piena realizzazione della nostra vocazione alla santità, la meta del nostro cammino esistenziale, la ricompensa che Dio ha preparato per chi rimane fedele alla chiamata a far parte della comunità dei santi. Lo Spirito Santo ci rende immagine e somiglianza di Gesù Cristo che a sua volta è il riflesso della santità del Padre. In Gesù è rivelato il volto misericordioso del Padre al quale assomigliare e verso il quale tendere. Come Gesù si è lasciato guidare e illuminare dallo Spirito Santo per essere «Luce delle genti», così il cristiano nel suo agire rende visibile l’amore misericordioso del Padre. Al principio della reciprocità Gesù oppone quello della mitezza: la vera resistenza è la resa. Le obiezioni al principio della reciprocità mettono in rilievo che quello della mitezza è in linea con la speranza a cui il cristiano deve tendere: essere figli dell’Altissimo. La vocazione dell’uomo è quella di essere ad immagine di Gesù e di riflettere (testimoniare) la gloria del Padre, il suo amore universale e gratuito.
La giustizia retributiva traduce in prassi il principio della reciprocità, mentre quello della gratuità ispira la giustizia di Dio che è «benevolo verso gli ingrati e i malvagi». Dio non vuole essere risarcito ma desidera che noi siamo liberi e gioiosi, santi come Lui. Nella misura ci si pone davanti a Dio come umili e poveri debitori si diventa capaci di rinunciare al giudizio e alla condanna nei confronti dei peccatori per poter offrire il perdono e condividere con generosità. Il giudizio e la condanna esprimono la pretesa di sostituirsi a Dio, piuttosto che imitarlo nella misericordia che cerca la riconciliazione e costruisce la relazione di comunione.
Nella prima parte della pericope il fine dell’amore fraterno è la edificazione della fraternità umana. Essa però è il primo passo verso una speranza più alta che si compirà con la risurrezione dopo la morte, allorquando Dio darà, come a Gesù un regno eterno, la fraternità dei santi. Nella seconda parte della pericope i verbi al presente indicano le opere da non fare e da fare per edificare ora la comunità fraterna e quelli al futuro passivo descrivono l’azione di Dio che da giudice giusto dà la ricompensa ai suoi servi fedeli introducendoli nella vita beata, nella comunità dei santi dove la misura dell’amore è amare senza misura.
MEDITATIO
La misericordia è la misura alta della gioia
Nella valle si sono radunati donne e uomini per ascoltare Gesù. La pianura non è solo un dato geografico ma indica la condizione terrena che accomuna tutti gli uomini. S. Paolo parla dell’uomo terreno, tratto dalla terra e fatto di terra, che ha un corpo animale in cui abita lo Spirito di Dio grazie al quale è essere vivente, sin dal momento del concepimento. Egli è creato non perché rimanga terreno ma per divenire “uomo celeste”, ovvero spirituale, capace di dare la vita. L’ “uomo terreno” produce e si riproduce mentre l’ “uomo celeste” è reso figlio di Dio e generatore di altri figli di Dio. Nella pagina del Vangelo Gesù, il Figlio dell’Altissimo, come lo ha chiamato l’angelo prima che venisse concepito nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, ovvero l’ “Uomo celeste” diventato “uomo terreno”, parla ai suoi fratelli, “uomini terreni”, indicando la strada per diventare “uomini celesti” simili a lui. La povertà, la fame, il dolore fisico e psichico ci danno la misura della nostra umanità così fragile, precaria e sterile. Eppure, Gesù rivolgendosi ai poveri, agli afflitti, agli affamati, ai perseguitati, alle vittime di ogni umana ingiustizia ha annunciato che Dio è con loro, li accompagna, li sostiene, li aiuta, li nutre, li difende se essi, confidando in Lui, si lasciano amare. Chi confida in Dio sperimenta il dono della pace nel cuore. Dal Crocifisso, l’uomo la cui immagine è deturpata dalla violenza verbale e fisica, e nel quale ogni povero si rispecchia, Dio fa scaturire il dono dello Spirito che trasforma il dolore in amore, la morte in vita. Gesù non salva sé stesso e gli altri dalla morte, ma attraverso la morte. Solo l’amore salva perché l’amore ha un enorme potere trasformante e generativo. Già, ma di quale amore parliamo. Gesù invita a puntare su un amore più grande, quello con il quale Dio ama il Figlio e anche noi. È un amore incondizionato e gratuito. Il peccato dell’uomo è quello di “misurare” l’amore di Dio usando criteri propriamente terreni che si ispirano al principio della reciprocità e del guadagno. Se manteniamo queste misure così ristrette anche la grazia di Dio, sebbene abbondante, sarà minima. La durezza con la quale giudichiamo, la diffidenza con cui ci approcciamo agli altri, la pretesa che alimentiamo nel cuore nell’atto di offrire non un servizio ma una prestazione, sono un filtro che non permette alla grazia di Dio di fecondare la nostra vita. L’obbedienza al Vangelo, ovvero la fede, passa attraverso le opere di misericordia: fare del bene e prestare senza aspettare un contraccambio. La ginnastica della misericordia fa sì che il cuore diventi più ricettivo della grazia di Dio e nel medesimo tempo più efficace nel trasmettere ciò che si è ricevuto. Infatti, l’amore non è semplice restituzione ma è comunicazione e tradizione. Amare i nemici, fare del bene a quelli che ci odiano, benedire chi ci maledice, pregare per coloro che ci maltrattano è possibile solo se apriamo il cuore ad accogliere, interiorizzare e mettere in pratica la Parola di Dio. Davide è un esempio di come è possibile fare propria la logica di Dio e agire secondo giustizia per invertire il senso di marcia della vendetta, affidando la propria causa a Dio. Amare i nemici è stato tradotto innanzitutto come un atto di rispetto nei confronti di chi, sebbene rappresentasse una minaccia per la sua vita, è riconosciuto come il consacrato di Dio la cui vita apparteneva a lui. Chi si affida nelle mani di Dio è certo che, se anche sembra essere in pugno ai più forti, il Suo amore è più forte. Davide risulta essere più debole rispetto a Saul e al suo esercito ma non confida nella fortuna di avere l’occasione per farsi giustizia da sé ma coglie l’opportunità di insegnare al re invidioso che con la mitezza si esercita il vero potere regale che è quello di dare la vita, non di toglierla.
ORATIO
Signore Gesù,
Maestro mite e umile di cuore,
insegnaci a saper ascoltare
la voce del Padre
al di là delle grida di chi
ci attacca e ci condanna.
Aiutaci a non alimentare le polemiche
e a non fomentare le guerre.
Ispiraci il coraggio
di contrastare con la carità
le derive delle ingiustizie.
Illumina i nostri occhi perché
possiamo vedere nel nemico che ci odia
un povero d’amore da amare.
Disarma la nostra mano
per renderla strumento della tenerezza
e della cura verso i bisognosi di affetto.
Donaci la mitezza
per lottare contro il male fatto dai cattivi
affinché la sapienza del Vangelo,
predicato e praticato
con le opere di misericordia,
converta il cuore dei peccatori
e orienti le loro scelte di vita
per la costruzione di una comunità
fondata sull’amore fraterno. Amen.